@Massimo Cella 2025 - Tutti i diritti riservati
Quando rivolgersi allo psicologo:
La presa di consapevolezza personale di stare attraversando un periodo della propria vita di disagio o di malessere psicologico è il campanello di allarme che, in un’ottica di prevenzione, dovrebbe indicare la necessità di richiedere un aiuto specialistico.
Da un punto di vista evolutivo, si può parlare degli stati di salute e di patologia mentale, che ogni individuo può incontrare nel corso della vita, come di passaggi sfumati e graduali, spesso reversibili, che si possono raggruppare in cinque condizioni:
· BENESSERE PSICHICO: condizione caratterizzata da un buon livello di soddisfazione dei bisogni, una soddisfacente qualità della vita, equilibrio, serenità, accettazione del proprio stato individuale e sociale (Fulcheri, 2004);
· DISAGIO PSICHICO: condizione caratterizzata da uno stato di sofferenza connesso a difficoltà di varia natura (affetti, lavoro, famiglia) che si presentano nella vita senza che si instauri alcun sintomo specifico ma tale da interferire nella propria quotidianità e nelle relazioni (Fulcheri, 2004);
· MALESSERE PSICHICO: condizione nella quale il disagio assume livelli di intensità più elevati, dove si manifesta la consapevolezza soggettiva di non stare bene (Fulcheri, 2004);
· DISTURBO PSICHICO: condizione in cui il soggetto non trova risoluzione alla sofferenza in cui lo pone la situazione di malessere, ovvero quando essa raggiunge livelli di intensità molto elevati ed è accompagnata da sintomi clinici o alterazioni del comportamento (Fulcheri, 2004);
· MALATTIA MENTALE CRONICA: condizione caratterizzata dal perdurare nel tempo delle alterazioni mentali o del comportamento ma anche delle situazioni che le hanno determinate (Fulcheri, 2004).
Cosa faccio:
Sostegno Psicologico
Il Sostegno psicologico è un intervento non terapeutico rivolto a chi vive un momento di disagio o crisi personale, ma che non presenta un quadro clinico tale da avere bisogno di un intervento terapeutico.
Consulenza psicologica
La consulenza psicologica è uno strumento che ha come obiettivo la comprensione e la definizione del problema e la ricerca di eventuali strategie di trattamento.
Si rivolge all’individuo in difficoltà allo scopo di fornire uno spazio di ascolto e di dialogo con un professionista ed è un intervento orientato alla valutazione del problema presentato e alla condivisione di un progetto d’intervento (stabilire un obiettivo, dare un’indicazione generale sui tempi e sulle modalità del lavoro), centrato sulla riflessione e approfondimento degli aspetti psicologici relativi al problema sollevato.
Psicoterapia
La psicoterapia individuale è un percorso di cura che mira alla soluzione del sintomo psicologico (ansia, depressione, disturbi psicosomatici etc.) e al miglioramento della qualità della vita.
Sostenuta nell’espressione del disagio e nella ricerca del suo significato, la persona in terapia esplora con il terapeuta la sua storia, riconosce i modelli relazionali appresi e costruisce spazi cognitivi e affettivi per nuove opportunità di pensiero, di azione e di relazione.
Il percorso di psicoterapia individuale favorisce, inoltre, la consapevolezza corporea e l’attenzione ai segnali di cui il corpo si fa spesso portavoce. Quando si ritiene necessario ci si avvale del supporto di altri professionisti (medici, psichiatri, etc. ) per offrire percorsi di cura il più possibile rispondenti alle esigenze specifiche delle persone.
Ansia:
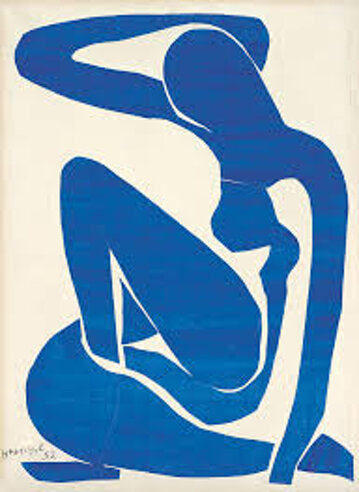
I Disturbi d’Ansia comprendono il disturbo d’ansia da separazione, il disturbo d’ansia generalizzata, il disturbo di panico, l’agorafobia, il disturbo d’ansia sociale, le fobie specifiche. Questi disturbi se persistenti ed eccessivi possono essere invalidanti e se non trattati possono cronicizzarsi diventando interferenti con le attività di vita quotidiana.
Ansia e Paura sono emozioni simili e non è sempre facile distinguerle. Entrambe hanno una componente cognitiva ed una reazione somatica che le accompagnano. La paura è la risposta emotiva ad un pericolo imminente, reale o percepito, mentre l’ansia è l’anticipazione di una minaccia futura; l’intensità di tale risposta emotiva sarà correlata alla minacciosità del pericolo, reale o percepito. La reazione somatica è una reazione di allarme dunque un aumento dell’attivazione del tono adrenergico che permette all’organismo di essere nella miglior condizione per combattere o fuggire e per far fronte al pericolo percepito. Si tratta di una risposta adattiva in quanto, se non eccessiva, determina il miglioramento della performance. Se però l’attivazione risulta quantitativamente amplificata e sproporzionata rispetto allo stimolo si può assistere ad un calo del rendimento fino ad una non funzionale ed adattiva disorganizzazione comportamentale.
I Disturbi d’Ansia differiscono tra loro per il tipo di situazioni che provocano ansia, paura oppure comportamenti di evitamento, e per la componente cognitiva (i pensieri) ad essi associati. Differiscono inoltre dalla normale ed adattiva paura o ansia a causa del loro eccessivo e persistente impatto emotivo.
L’intervento dello psicologo o dello psicoterapeuta è utile per aiutare a riconoscere i triggers cioè quelle situazioni o eventi che provocano uno stato ansioso e ad aiutare ad affrontarle in maniera più funzionale ed adattiva. Inoltre è utile per imparare a riconoscere ed a modificare i pensieri ripetitivi negativi che stanno alla base dell’ansia. Essere in uno stato d’ansia o di forte stress per troppo tempo è dannoso non solo per la nostra salute mentale ma anche per quanto riguarda il benessere del nostro corpo. L’esposizione infatti ad eccessive quantità di ormoni come il cortisolo o l’adrenalina che vengono rilasciati dal nostro corpo quando ci sentiamo in pericolo, ci impedisce di espletare ad altre funzioni fisiologiche necessarie al nostro organismo quali dormire, digerire e rigenerarsi.
Nel disturbo d’ansia da separazione la persona è ansiosa o spaventata riguardo alla possibilità di una separazione o di una perdita delle figure di attaccamento;
nel disturbo d’ansia generalizzato emergono ansia e preoccupazione eccessive e persistenti riguardanti diversi ambiti che l’individuo ha difficoltà a controllare. Emergono sintomi fisici quali tensione, agitazione, irritabilità, difficoltà di attenzione e concentrazione, vuoti di memoria, tensione muscolare e alterazione del ciclo sonno-veglia;
nel disturbo di panico si presentano ricorrenti ed inaspettati attacchi di panico, rappresentati dall’improvvisa comparsa di paura o disagio intensi accompagnati da sintomi fisici quali tachicardia, aumentata sudorazione, senso di oppressione al petto, sensazione di soffocamento, tremori, vertigini e sensazione di instabilità e mancato equilibrio, vampate di calore o brividi, sensazione di torpore o formicolio a parti del corpo, paura di perdere il controllo, paura di morire. Gli attacchi di panico possono essere attesi, come risposta ad una situazione usualmente temuta, o inaspettati, se si verificano cioè senza un’evidente ragione;
nell’agorafobia le persone possono essere ansiose o spaventate in diverse situazioni quali l’utilizzo dei trasporti pubblici, il trovarsi in spazi aperti oppure ristretti (claustrofobia), stare in mezzo a tante persone, in fila oppure uscire da soli. Le persone che ne soffrono temono che in tali situazioni possa essere difficile fuggire o chiedere soccorso qualora dovessero emergere sensazioni simili al panico. Tali contesti vengono evitati o richiedono la presenza di un accompagnatore;
nel disturbo d’ansia sociale le persone provano ansia o paura ed evitano le interazioni sociali in cui possono incontrare degli sconosciuti o in cui può emergere il timore di essere valutati negativamente o essere imbarazzati o rifiutati;
nelle fobie specifiche l’ansia e la paura sono collegate all’esposizione a oggetti o situazioni circoscritte con il conseguente comportamento di evitamento degli stessi. Tali emozioni non sono accompagnate da un pensiero specifico. Vi sono vari tipologie di fobie specifiche quali animali, ambienti naturali, sangue-iniezioni-ferite.
E’ un’emozione che, al contrario della paura, deriva da un pericolo futuro ed incerto; ci segnala che c’è qualcosa che potrebbe accadere e che potremmo non riuscire ad affrontare.
E’ quindi generata più dai pensieri relativi ad un evento, che dall’evento stesso come invece potrebbe essere la paura. Di per sé non è quindi patologica, anzi si è evoluta per permetterci di sopravvivere ed evitare i pericoli potenzialmente fatali.
L’ansia è classificata quindi come un’emozione adattiva che però può diventare rapidamente un disturbo se viene provata intensamente per lunghi periodi.
In quali casi quindi, si può parlare di ansia patologica?
Si può parlare di patologia quando l’ansia perde la sua caratteristica di funzionalità: quando viene provata frequentemente in più contesti, anche e soprattutto quando non c’è un pericolo vero a proprio.
In questi casi può essere di grande aiuto uno psicologo o uno psicoterapeuta. Nell’ultimo periodo infatti si sono sviluppate diverse psicoterapie e interventi, operati però sempre da psicologi o psicoterapeuti, per rispondere alla maggiore richiesta da parte delle persone di tecniche e metodi per gestire gli stati ansiosi in cui si ritrovano.
L’intervento di uno psicologo può aiutarci a riconoscere i triggers, cioè quelle situazioni o eventi che ci provocano uno stato d’ansia e, al contempo, insegnarci determinate tecniche per affrontarli in maniera più adattiva.
In ogni caso, è bene tenere presente che essere in uno stato d’ansia o di forte stress per lunghi periodi è deleterio non solo per la nostra salute psicologica, ma anche per quanto riguarda il benessere del nostro corpo.
I nostri pensieri infatti agiscono direttamente sul nostro fisico grazie a degli ormoni come il cortisolo e l’adrenalina, che vengono rilasciati quando ci sentiamo in pericolo.
Quando proviamo ansia si attiva infatti un insieme di circuiti cerebrali che innescano il sistema di attacco e fuga (fight or flight) che prepara il nostro corpo a rispondere ad un’eventuale minaccia; essere però spesso in questo stato, ci impedisce di espletare altre funzioni per cui il nostro corpo deve necessariamente essere tranquillo come dormire, digerire e rigenerarsi.
Una mancanza di sonno prolungata dovuta a difficoltà a dormire, spesso determinata all’ansia, può avere effetti deleteri sulle nostre funzioni cognitive superiori, come la concentrazione, l’attenzione e la regolazione emotiva.
Un ulteriore aiuto che può venire dalla psicologia riguarda quelle tecniche di rilassamento che possono aiutare ad avere un sonno più riposante.
Queste strategie permettono di imparare a riconoscere e bloccare pensieri ripetitivi negativi che stanno alla base dell’ansia, accettandoli e mettendoli da parte con pazienza ed empatia verso se stessi.
Un consiglio generale, soprattutto quando si parla di problematiche psicologiche, è di non aspettare che la situazione diventi grave o addirittura ingestibile prima di chiedere aiuto ad un professionista.
L’ansia non diventa patologica in breve tempo, ma è il risultato di mesi, se non addirittura anni, di pattern di pensiero disadattivi.
Chiedere aiuto quando il disagio è agli inizi, permette di ottenere risultati migliori e più veloci in terapia, evitando anche sofferenza alla persona stessa: non è mai sciocco chiedere aiuto, se ci si sente in difficoltà!
Depressione:
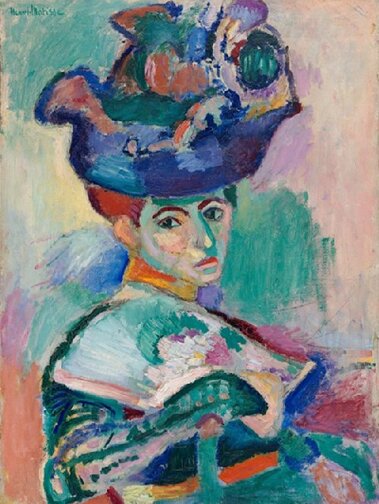
I Disturbi Depressivi sono costituiti da un gruppo di quadri clinici in cui è possibile rintracciare come elemento psicopatologico fondamentale un’alterazione significativa dell’affettività, cioè della condizione emotiva dell’esistenza umana. La caratteristica che accomuna questi disturbi è la presenza di umore triste, sensazione di vuoto o irritabilità accompagnata da modificazioni somatiche e cognitive che possono incidere significativamente sulle capacità di funzionamento ed adattamento dell’individuo. I disturbi depressivi causano un significativo disagio o compromissione del funzionamento in ambito affettivo, sociale e lavorativo.
Il Tono dell’Umore, definibile come quell’emozione prolungata che dà una coloritura alla vita psichica, invece di oscillare fisiologicamente fra i due poli rappresentati dalla tristezza e dalla gioia, si stabilizza stabilmente e patologicamente sul polo negativo, in una condizione depressiva.
La depressione è uno dei disturbi psichici più comuni e invalidanti, derivante spesso a seguito di una sensazione di perdita o di una perdita effettiva. La percentuale di persone che soffrono di depressione sembra aumentare costantemente nel tempo e, non a caso, l’OMS ha previsto che nel giro di pochi anni la depressione sarà la seconda causa di invalidità per malattia, subito dopo le malattie cardiovascolari.
In generale, sentirsi depressi significa vedere il mondo attraverso degli occhiali con le lenti opache: tutto sembra più difficile da affrontare, anche alzarsi dal letto al mattino o fare una doccia; molte persone depresse hanno la sensazione che gli altri non possano comprendere il loro stato d’animo e che siano inutilmente ottimisti.
Tuttavia le cause della depressione restano molteplici e diverse da persona a persona (ereditarietà, ambiente sociale, lutti familiari, problemi di lavoro,…). Le ricerche mostrano la presenza di tre fattori di rischio principali come fattori di rischio e prognostici nella depressione:
- il fattore biologico o genetico e fisiologico: alcune persone nascono con una maggiore predisposizione genetica verso la depressione;
- il fattore temperamentale o psicologico: le esperienze e i comportamenti appresi nel corso della propria storia di vita possono rendere vulnerabili alla depressione;
- il fattore ambientale: il contesto socio-relazionale di appartenenza.
Uno dei trattamenti preferenziali è la psicoterapia a volte abbinata ad un trattamento farmacologico per i casi più gravi.
Il Disturbo Depressivo Maggiore rappresenta la condizione classica in questo gruppo di disturbi ed è caratterizzato da episodi che determinano importanti modificazioni emotive, affettive, cognitive e nelle funzioni neurovegetative; nella maggior parte dei casi il disturbo è ricorrente. Oltre alla deflessione del tono dell’umore, emergono una diminuzione di piacere o interesse nello svolgere le attività di vita quotidiana, alterazione del ciclo sonno-veglia con insonnia o ipersonnia, alterazione del comportamento alimentare con aumento o diminuzione dell’appetito, agitazione o rallentamento psicomotorio , mancanza di energia ed affaticamento, pensieri e sentimenti di colpa o di autosvalutazione, alterazione delle funzioni di attenzione-concentrazione-memoria, pensieri di morte.
Il Disturbo Depressivo Persistente o Distimia, è una forma di depressione più cronica, permanente e stabile nel tempo. La depressione maggiore può precedere il disturbo depressivo persistente ed episodi depressivi maggiori possono occorrere episodicamente nello stesso.
Vi sono poi disturbi depressivi che possono correlarsi al ciclo mestruale o essere indotti dall’uso/abuso di sostanze stupefacenti o di farmaci.
EMDR:
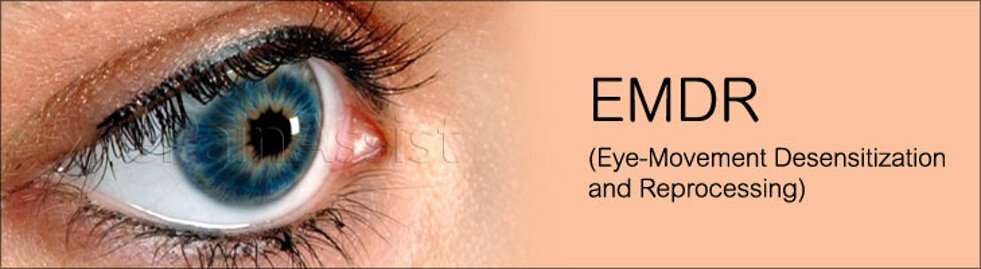
L’EMDR acronimo di Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso i movimenti oculari) è un trattamento psicoterapeutico strutturato ed integrato innovativo ideato nel 1989 dalla psicologa americana Francine Shapiro e rivolto al trattamento di pazienti che presentano una condizione generale di distress psicologico dovuta ad un evento traumatico, recente o remoto, particolarmente impattante a livello emotivo.
Questa metodologia fu introdotta nel 1989 con dei primi studi controllati che valutavano gli effetti di una sessione di trattamento con veterani di guerra o persone che avevano subito abusi sessuali (Shapiro, 1989) e si è da subito dimostrata efficacie nell’alleviare lo stress e i sintomi associati a ricordi traumatici.
L’EMDR è stato inserito nel 2004 nelle linee guida dell’American Psychiatric Association come trattamento evidence-based come intervento specifico per il Disturbo Post-Traumatico da Stress; nel 2013 anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l’EMDR come trattamento efficacie per la cura del trauma psichico e dei disturbi ad esso correlati.
EMDR E’ BASATO SUL MODELLO DELL’ELABORAZIONE ADATTIVA DELL’INFORMAZIONE (AIP)
Tutti gli esseri umani hanno un sistema fisiologico innato di elaborazione dell’informazione per far fronte alla molteplicità degli elementi che caratterizzano le nostre esperienze e per immagazzinare i relativi ricordi in una forma accessibile e funzionale.
Il modello teorico dell’EMDR stima che le esperienze traumatiche o altamente stressanti possono essere memorizzate come ricordi in modo disfunzionale a causa dell’impatto emotivo nel momento dell’esperienza. Il cambiamento terapeutico che si verifica dopo un intervento con l’EMDR è il risultato dell’elaborazione e del processamento di queste esperienze e ne consente una risoluzione adattiva.
Shapiro ritiene che l’EMDR possa essere utile a curare i sintomi di molti disordini psichici attraverso l’elaborazione dei ricordi disturbanti di eventi di vita che hanno contribuito a sviluppare tali patologie.
TRAUMI CON LA “T” MAIUSCOLA E LA “t” minuscola
Shapiro ha suddiviso in due macro-categorie i traumi psicologici (Trauma dal greco “ferite dell’anima”) ai quali tutti quanti noi, in quanto esseri umani, possiamo essere esposti nel corso del nostro ciclo di vita.
Definiamo i Traumi con la “T maiuscola” come ferite importanti che minacciano la nostra integrità, la nostra vita o assistiamo all’evento che ha come protagoniste persone a noi vicine. Parliamo ad esempio di calamità naturali, incidenti stradali, violenze sessuali, aggressioni, omicidi o suicidi di persone care, diagnosi infauste. Conseguentemente le persone possono reagire con “paura, senso di vulnerabilità e orrore” (DSM-V, 2013) reazioni descritte riguardo la sintomatologia emergente da un Disturbo da Stress Post Traumatico. In questi casi il trauma appartiene al nostro presente, le sensazioni corporee e le immagini del ricordo sono vivide, l’impatto emotivo dell’evento viene ri-vissuto come se stesse accadendo ora anche se risale a mesi o anni addietro, possiamo essere esposti a flashback o avere incubi molto disturbanti.
Ma vi son anche traumi che definiamo con la “t minuscola”, esperienze che apparentemente hanno una minore rilevanza ad impatto emotivo ma che possono assumere una notevole incidenza soprattutto se reiterate nel tempo o subite in momenti di particolare vulnerabilità come ad esempio nell’infanzia. Trascuratezza, abbandoni, umiliazioni e paure possono lasciare il segno modificando i nostri comportamenti, le nostre emozioni, i nostri pensieri e interferire nella qualità delle relazioni interpersonali. La sofferenza psicologica conseguente a questa categoria di traumi può essere meno impattante ma nonostante ciò ugualmente invalidante. Sensazione di insicurezza, scarsa autostima, sensi di colpa, attacchi di panico, disturbi ansioso-depressivi possono essere le conseguenze più frequenti.
LA SEDUTA DI EMDR
Nel corso della prima fase di una seduta EMDR lo psicoterapeuta raccoglie la storia del paziente identificando con lui gli eventi che hanno contribuito a sviluppare il problema attuale: questi saranno i ricordi che verranno elaborati con l’EMDR. Il paziente viene quindi invitato a notare i pensieri, le sensazioni fisiche e le immagini collegate con l’esperienza traumatica mentre il terapeuta gli fa compiere dei semplici movimenti oculari procedendo con stimolazioni alternate destra-sinistra. Tali stimolazioni facilitano l’interconnessione tra gli emisferi cerebrali e si basano su un naturale processo neurofisiologico, simile a quello che avviene nella fase di sonno REM durante la quale si sogna.
In seguito alle stimolazioni bilaterali alternate dell’EMDR il paziente ricorda ancora l’evento traumatico ma sente che appartiene al passato ed è integrato in una prospettiva più adulta ed adattiva. Durante il processo si possono provare emozioni intense ma al termine della seduta il paziente esperisce una notevole riduzione del livello di disturbo associato all’esperienza traumatica. I ricordi disturbanti si modificano, i pensieri e le immagini intrusive si affievoliscono o svaniscono, le emozioni e le sensazioni fisiche si riducono di intensità.
In seguito ad una psicoterapia con l’EMDR il soggetto rafforza gli aspetti della sua autostima, è più centrato sul qui-ed-ora e sul senso del sé, ha più fiducia nelle sue capacità e nel suo valore come persona.
Gli eventi traumatici perdono l’iniziale impatto emotivo per trasformarsi in una risorsa positiva. Con la terapia EMDR si acquista la consapevolezza che ciò che è successo non si può cambiare ma il ricordo dell’evento traumatico può essere trasformato e convertito in una risorsa efficace e funzionale per il proprio benessere.
L’EFFICACIA DELL’EMDR OLTRE IL DISTURBO DA STRESS POST TRAUMATICO
Le applicazioni cliniche della terapia EMDR sono state sono state largamente studiate con diversi disturbi come:
· Fobie
· Attacchi di panico
· Disturbi d’ansia
· Depressione
· Lutti complessi
· Disturbi dissociativi
Via Cristoforo Colombo 13, 10128 Torino
+39 3381870022
p.Iva 09265190018
Massimo Cella
Psicologo Psicoterapeuta
